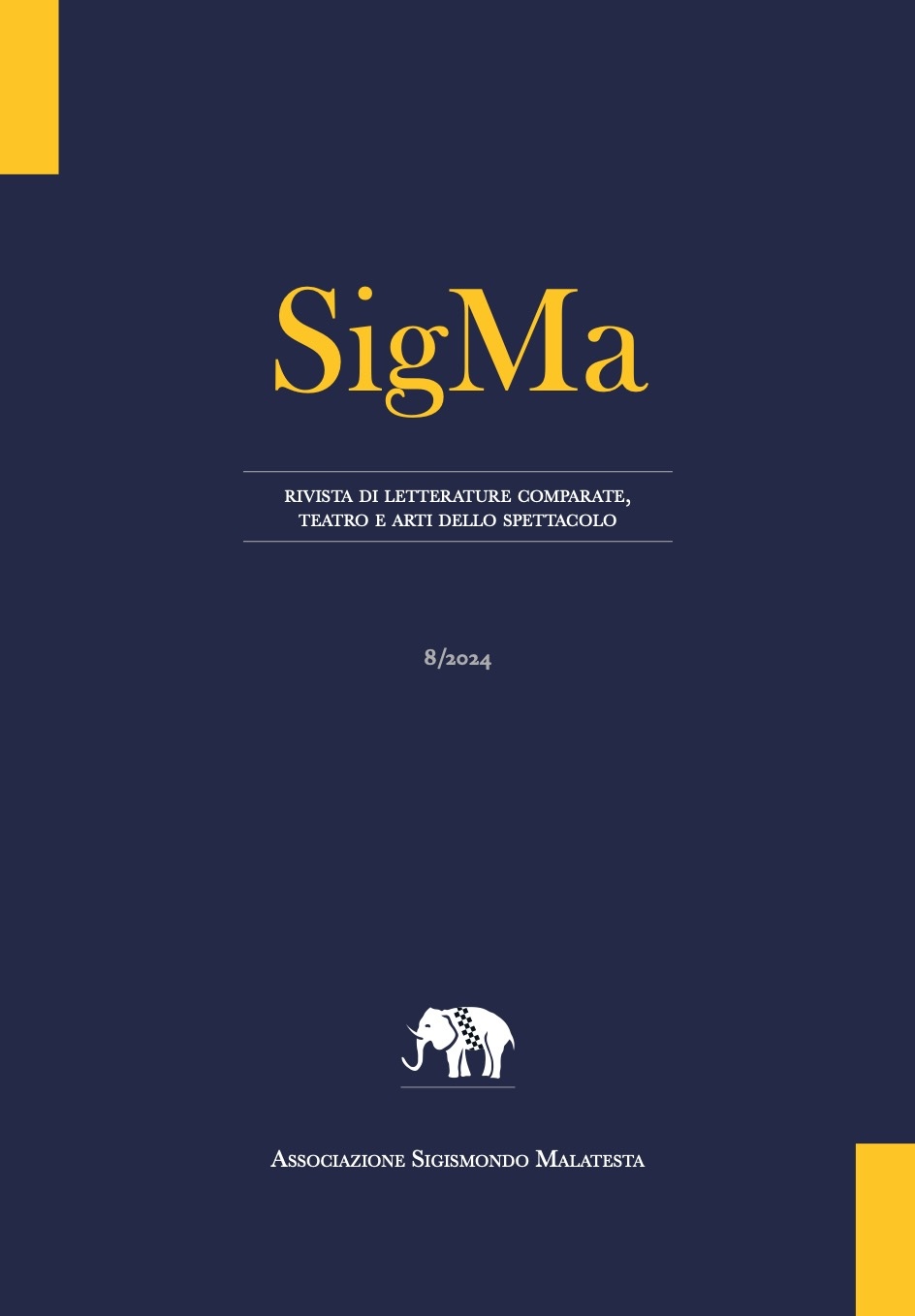Il coro dell’opera barocca sulla scena contemporanea: problemi formali e soluzioni registiche
Abstract
Quando pensiamo alla coralità nell’opera in musica della tradizione italiana, vengono subito alla mente le imponenti masse corali del melodramma ottocentesco, capaci di suscitare nello spettatore un impatto emotivo forte, ma la cui rilevanza nell’economia complessiva dell’azione drammatica è il più delle volte piuttosto marginale e secondaria. Al contrario, nell’opera cosiddetta ‘delle origini’ il coro e la coralità rivestono una importanza fondamentale non solo sul piano scenico e musicale, ma anche nella costruzione drammaturgica. La mancanza di una trasmissione diretta delle tradizioni e delle consuetudini rappresentative dei melodrammi del primo Seicento, come pure l’instabilità dello statuto dei testi musicali che li conservano, pongono delle criticità operative per i registi che debbano oggi confrontarsi con la loro messinscena. Questo contributo si propone di indagare tali criticità con particolare riferimento all’Orfeo (1607) di Claudio Monteverdi con libretto di Alessandro Striggi, attraverso l’analisi di due produzioni che risultano significative di diversi approcci al testo di partenza e, più in generale, di differenti tendenze della regìa d’opera contemporanea.
Downloads
SigMa pubblica in internet, ad accesso aperto, con licenza:
|
|
CCPL Creative Commons Attribuzione |
L'autore conserva il copyright sul suo contributo, consentendo tuttavia a chiunque "di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare l'opera", purché siano correttamente citati l'autore e il titolo della rivista. L’autore, al momento della proposta di pubblicazione, è inoltre tenuto a dichiarare che il contenuto e l’organizzazione dell’opera è originale e non compromette in alcun modo i diritti di terzi, né gli obblighi connessi alla salvaguardia di diritti morali ed economici di altri autori o di altri aventi diritto, sia per testi, immagini, foto, tabelle, sia per altre parti di cui il contributo può essere composto. L’autore dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali per l’ipotesi di falsità in atti ed uso di atti falsi, e che pertanto Reti Medievali è esente da qualsiasi responsabilità di qualsivoglia natura, civile, amministrativa o penale, e sarà dall'autore tenuta indenne da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi.