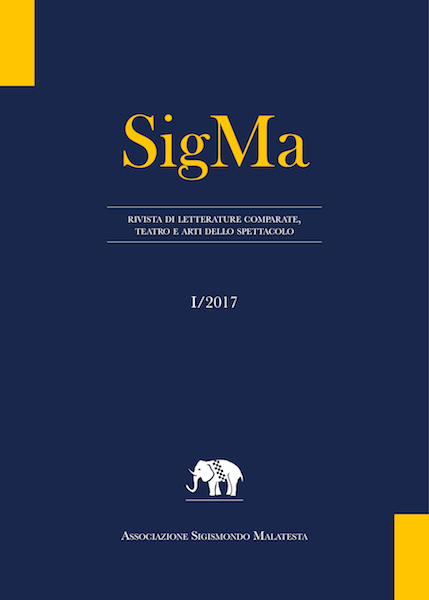Giorgio Manganelli tra “opera aperta” e “opera chiusa”
Abstract
Nel marzo del 1969, all’indomani di un’entusiastica lettura in manoscritto di Nuovo commento, Italo Calvino indirizza a Giorgio Manganelli una lettera che rappresenta non solo la prima, ma anche – per molti aspetti – una già caratterizzante interpretazione dell’opera. Calvino scopre subito le sue carte: assecondando, dice di se stesso, “quel fanatico dell’‘opera chiusa’ e degli schemi lineari che alberga in me”, dichiara di essere andato alla ricerca nel testo di uno o più “sistemi” ordinativi interni. Pur avendo trovato varie “struttur[e] […] pertinent[i]”, e quindi per lui di particolare soddisfazione, Calvino conclude “col consiglio di […] completare l’incastratura di tutto nel tutto per rendere il tutto compatto come un uovo”. Un modo, in omaggiante stile manganelliano, per ribadire la propria ferrea istanza di chiusura. Nuovo commento però – come del resto quasi tutti i testi manganelliani – è tutt’altro che un’“opera chiusa”. Si propone, anzi, per programma come un’“opera aperta”: dove – seguendo la fortunata formula di Umberto Eco (enunciata solo pochi anni prima e implicita, per contrasto, nello stesso discorso di Calvino) – l’apertura non è tanto (o soltanto) nell’atto di fruizione, ma presupposta nello stesso atto narrativo, in una scrittura cioè da un lato (potenzialmente) infinita, dall’altro “scostata e dall’inizio e dalla fine”, sviluppata in uno “spazio mediano” (con tutta la problematicità che hanno in Manganelli, occorre ricordarlo, le categorie di “centro” e “periferia”). Del resto, pur interrompendosi, le sue opere non ‘finiscono’ propriamente; un aspetto, questo, che è evidente pure dal trattamento che proprio l’apocalisse – il modello-archetipo narrativo-cognitivo scelto da Kermode per indagare il Sense of an Ending – ha nei testi manganelliani.
Downloads
SigMa pubblica in internet, ad accesso aperto, con licenza:
|
|
CCPL Creative Commons Attribuzione |
L'autore conserva il copyright sul suo contributo, consentendo tuttavia a chiunque "di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare l'opera", purché siano correttamente citati l'autore e il titolo della rivista. L’autore, al momento della proposta di pubblicazione, è inoltre tenuto a dichiarare che il contenuto e l’organizzazione dell’opera è originale e non compromette in alcun modo i diritti di terzi, né gli obblighi connessi alla salvaguardia di diritti morali ed economici di altri autori o di altri aventi diritto, sia per testi, immagini, foto, tabelle, sia per altre parti di cui il contributo può essere composto. L’autore dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali per l’ipotesi di falsità in atti ed uso di atti falsi, e che pertanto Reti Medievali è esente da qualsiasi responsabilità di qualsivoglia natura, civile, amministrativa o penale, e sarà dall'autore tenuta indenne da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi.