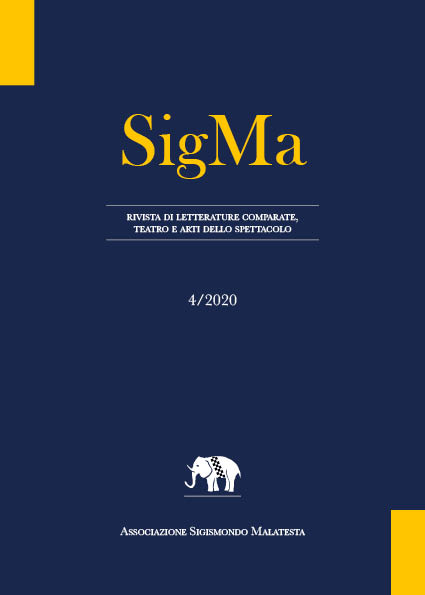Ermafrodito amoroso e ragione senza genere: Tullia d’Aragona e Benedetto Varchi nel “Dialogo dell’infinità d’amore”
Abstract
In questo contributo si esamina da diversi punti di vista il Dialogo dell’infinità d’amore della cortigiana cinquecentesca Tullia d’Aragona e il suo contesto storico. La ricostruzione muove dalla premessa di una collaborazione fra la scrittrice e l’esperto letterato Benedetto Varchi che inserisce organicamente la promozione culturale della donna in un ambizioso disegno di divulgazione filosofica in volgare toscano. L’immagine della femina docta trasmessa dal Dialogo viene confrontata con il modello contemporaneo e concorrente del Dialogo d’amore di Sperone Speroni, maestro del Varchi ma anche suo implicito termine di riferimento polemico. Mentre in questo testo la donna appare relegata a un livello inferiore di irrazionalità amorosa, il Dialogo dell’infinità d’amore assicura al personaggio “Tullia” una notevole autonomia come soggetto raziocinante. Si considera poi il ruolo di Girolamo Muzio, editore del Dialogo, in rapporto alla raccolta di Rime della poetessa di cui si esamina la collocazione nel dibattito religioso in corso e la presa di distanza dalle tendenze “evangeliche” e filoprotestanti. Si discute successivamente la posizione del Dialogo dell’infinità d’amore nell’ambito dell’aristotelismo in volgare del primo Cinquecento, con le sue opposte tendenze alessandriste, averroiste o platonizzanti, e ai dibattiti speculativi sull’infinito e l’immortalità dell’anima, constatando il gioco delle parti fra gli interlocutori che consente di evitare conclusioni eterodosse. Si dedica infine un’ampia analisi ai Dialoghi d’amore di Leone Ebreo come fonte principale del testo di Tullia e di Varchi, tenendo conto di una fondamentale differenza di registro che riconduce il misticismo intellettuale dell’autore sefardita a una misura più terrena e mondana.
Downloads
SigMa pubblica in internet, ad accesso aperto, con licenza:
|
|
CCPL Creative Commons Attribuzione |
L'autore conserva il copyright sul suo contributo, consentendo tuttavia a chiunque "di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare l'opera", purché siano correttamente citati l'autore e il titolo della rivista. L’autore, al momento della proposta di pubblicazione, è inoltre tenuto a dichiarare che il contenuto e l’organizzazione dell’opera è originale e non compromette in alcun modo i diritti di terzi, né gli obblighi connessi alla salvaguardia di diritti morali ed economici di altri autori o di altri aventi diritto, sia per testi, immagini, foto, tabelle, sia per altre parti di cui il contributo può essere composto. L’autore dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali per l’ipotesi di falsità in atti ed uso di atti falsi, e che pertanto Reti Medievali è esente da qualsiasi responsabilità di qualsivoglia natura, civile, amministrativa o penale, e sarà dall'autore tenuta indenne da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi.