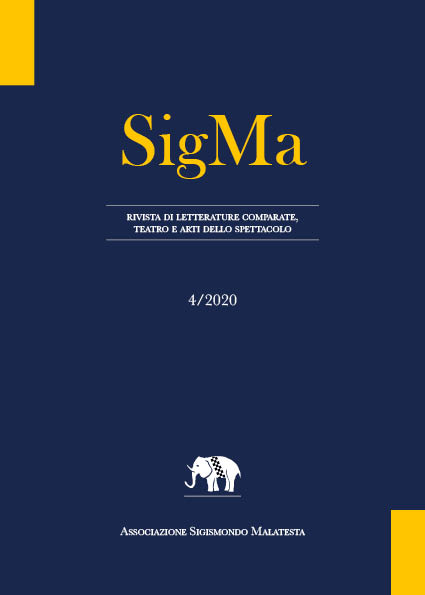A brandelli. Sul “Woyzeck” di Büchner
Abstract
Il lavoro si propone di analizzare il Woyzeck di Büchner secondo una prospettiva genetica, mettendone in evidenza il progressivo emergere della tematica politica e sociale a partire dalla vicenda passionale di cronaca che ha ispirato il dramma, oltre che dall’evidente e multiforme influenza di Shakespeare. La tematica della gelosia e quella della follia si intrecciano in modo estremamente funzionale con la messa in scena dell’umiliazione individuale; il risultato è un dramma sulla sconfitta e sulla sopraffazione violenta (fisica, gerarchica, politica) dell’uomo sull’uomo. Il gelido sguardo büchneriano su questa disposizione del mondo, come sappiamo dalle altre opere, dalle lettere e dalla stessa biografia, non è affatto uno sguardo rassegnato; però nel caso di Woyzeck la reazione all’ingiustizia si manifesta soprattutto sul piano individuale, e non come ribellione violenta, ma come un deragliamento dai binari cognitivi condivisi con la collettività, una fuga nella follia che è soprattutto un sottrarsi a un universo reso dalla sconfitta e dall’ingiustizia ormai intollerabile, oltre che privo di qualsiasi – anche simbolica – forma di riscatto. Da un punto di vista formale, viene studiata la frammentarietà del dramma, dovuta non solo alla sua condizione di opera incompiuta, ma anche alla scelta deliberata dell’autore di produrre un teatro dove le singole scene acquisiscono senso isolatamente più che nelle loro reciproche relazioni. Questo da un lato riflette lo sgretolamento della psiche del protagonista; dall’altro rende problematica un’interpretazione normativa, che si pretenda sistematica e coerente, e che in questo modo si lascia sfuggire la sostanza umana dell’opera büchneriana.
Downloads
SigMa pubblica in internet, ad accesso aperto, con licenza:
|
|
CCPL Creative Commons Attribuzione |
L'autore conserva il copyright sul suo contributo, consentendo tuttavia a chiunque "di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare l'opera", purché siano correttamente citati l'autore e il titolo della rivista. L’autore, al momento della proposta di pubblicazione, è inoltre tenuto a dichiarare che il contenuto e l’organizzazione dell’opera è originale e non compromette in alcun modo i diritti di terzi, né gli obblighi connessi alla salvaguardia di diritti morali ed economici di altri autori o di altri aventi diritto, sia per testi, immagini, foto, tabelle, sia per altre parti di cui il contributo può essere composto. L’autore dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali per l’ipotesi di falsità in atti ed uso di atti falsi, e che pertanto Reti Medievali è esente da qualsiasi responsabilità di qualsivoglia natura, civile, amministrativa o penale, e sarà dall'autore tenuta indenne da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi.