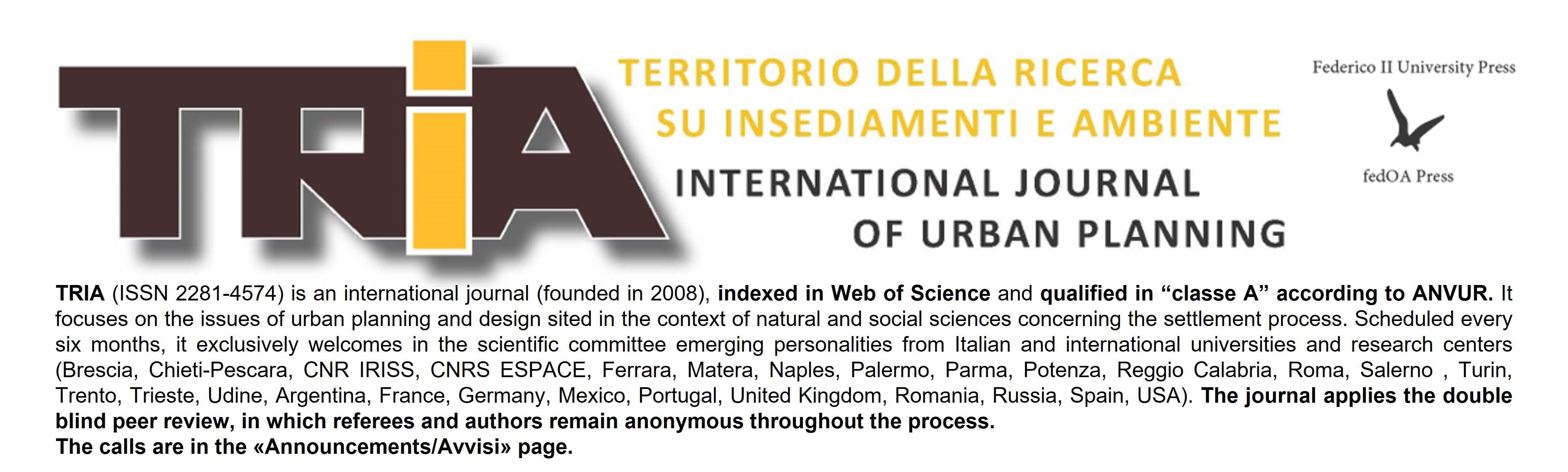Ambito scientifico e Comitato Scientifico Internazionale
TRIA (ISSN 2281-4574) è una rivista internazionale (fondata nel 2008), indicizzata in Web of Science e abilitata alla classe A dall’ANVUR, incentrata sulle tematiche della pianificazione e della progettazione urbanistica inserite nel più ampio contesto delle scienze naturali e di quelle sociali interessanti la processualità insediativa. Programmata con periodicità semestrale, accoglie nel comitato scientifico esclusivamente personalità emergenti delle principali università degli studi e centri di ricerca italiani e internazionali (Brescia, Chieti-Pescara, CNR IRISS, CNRS ESPACE, Ferrara, Matera, Napoli, Palermo, Parma, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Udine, Argentina, Francia, Germania, Messico, Portogallo, Regno Unito, Romania, Russia, Spagna, USA).
Valutazione delle submission e peer review
Tutti gli articoli vengono valutati in una prima fase dagli editor, i quali possono decidere di rifiutare l'articolo, perché considerato non sufficientemente originale o al di fuori delle finalità e dell'ambito della rivista. Gli articoli che soddisfano questi criteri minimi vengono inoltrati ad almeno due esperti per iniziare la fase revisione. Questa rivista impiega la doppia revisione cieca, in cui i referee e gli autori restano anonimi per tutto il processo.