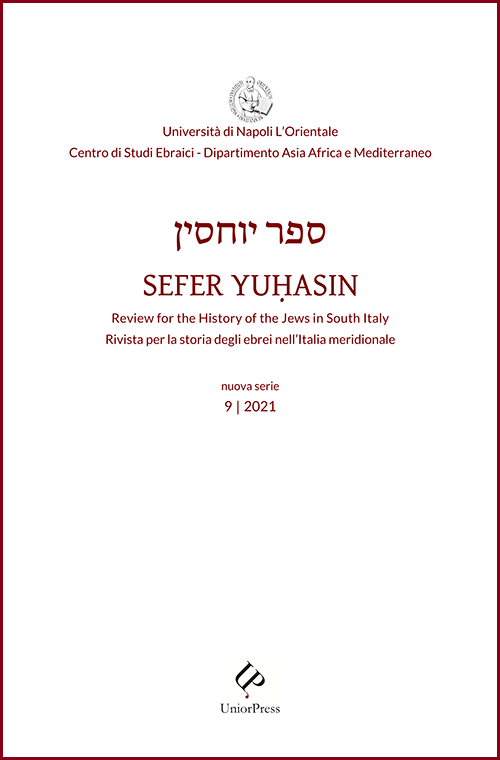Manigoldi ebrei nel medioevo: rassegna critica e nuove notizie da Candia
Abstract
Nel 1431 Mošeh de Bonavoglia, giudice generale delle comunità ebraiche siciliane, inoltrava una supplica ad Alfonso il Magnanimo affinché mettesse fine a quello che per gli ufficiali del re era ormai diventato un costume: costringere gli ebrei a eseguire le pene capitali e corporali comminate dai tribunali ai danni di cristiani. Qual era stata l’origine di tale costume – il quale, non precedentemente attestato, rimase in voga fino all’espulsione? L’articolo parte da una rassegna critica dei documenti che attestano l’impiego di ebrei come manigoldi – prima nell’impero bizantino e nell’impero bulgaro e, più tardi, nella Corfù angioina, nella Creta veneziana, in Sicilia, a Modone, a Corone e a Napoli – e della letteratura secondaria sul tema. L’attenzione si sposta quindi su Candia, dove tra il 1389 e il 1527 è documentato un impiego pressoché sistematico di manigoldi ebrei (la maggioranza dei quali siciliani). È convinzione invalsa che la costrizione imposta agli ebrei di ricoprire l’incarico di manigoldi fosse un retaggio dell’impero bizantino. Nell’impero bizantino, però, tale costrizione è attestata con estrema sporadicità. Qualunque sia stata l’origine dell’impiego di ebrei come manigoldi, le attestazioni più antiche del loro impiego sistematico in questo ruolo provengono tutte da colonie latine nate su territori precedentemente bizantini. Tale impiego sistematico possa essere interpretato come indizio della resistenza opposta dalla popolazione autoctona greca al potere veneziano e angioino e potrebbe essere stato introdotto in Sicilia soltanto in un secondo momento.
Downloads
Gli autori che pubblicano su questa rivista accettano le seguenti condizioni:
- Gli autori mantengono i diritti sulla loro opera e cedono alla rivista il diritto di prima pubblicazione dell'opera, contemporaneamente licenziata sotto una Licenza Creative Commons - Attribuzione che permette ad altri di condividere l'opera indicando la paternità intellettuale e la prima pubblicazione su questa rivista.
- Gli autori possono aderire ad altri accordi di licenza non esclusiva per la distribuzione della versione dell'opera pubblicata (es. depositarla in un archivio istituzionale o pubblicarla in una monografia), a patto di indicare che la prima pubblicazione è avvenuta su questa rivista.
- Gli autori possono diffondere la loro opera online (es. in repository istituzionali o nel loro sito web) prima e durante il processo di submission, poiché può portare a scambi produttivi e aumentare le citazioni dell'opera pubblicata (Vedi The Effect of Open Access).